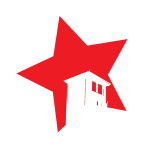Siamo quel che mangiamo? O mangiamo quello che siamo?
È fondamentale trovare una risposta a questa domanda per affrontare con consapevolezza qualsiasi discussione riguardo a uno dei pochi argomenti che ancora riescono ad appassionare milioni di italiani: il cibo.
Il nostro modo di mangiare, così come quello di vestire o abitare una casa, è espressione diretta “dei rapporti sociali nel loro complesso”. Lo diceva anche Antonio Gramsci nel suo “Il materialismo storico”, fornendoci uno degli elementi da cui far partire il ragionamento.
Non è un caso, infatti, che la storia sia costellata di moti e rivolte contadine che non si ponevano l’obiettivo di mutare le abitudini alimentari della popolazione, ma piuttosto di modificare radicalmente il corso degli eventi e di ridefinire, appunto, i rapporti sociali che li inquadravano come appartenenti ad una classe povera e priva di risorse intellettuali e materiali.
Le nostre abitudini, comprese quelle alimentari, sono dunque frutto delle trasformazioni e dello sviluppo storico. E non viceversa. Non possiamo pensare di essere motore del cambiamento modificando i nostri consumi, senza puntare ad una trasformazione complessiva.
Perchè?
Giovedì 20 settembre inaugura a Torino il XII Salone del Gusto “Terra Madre”, promosso da Slow Food, Regione Piemonte, Comune di Torino e dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Quattro giorni dedicati al comparto agroalimentare e alle eccellenze italiane con un solo mantra: #foodforchange. Il cibo del cambiamento, nella narrazione di questo evento/vetrina dei migliori prodotti italiani, è quello “buono, giusto e pulito” marchiato Slow Food, l’associazione fondata da Carlo Petrini, promotore di un’agricoltura più bio e compatibile.
Una filosofia che attrae il consumatore attento e sensibile, pur dando forma ai suoi peggiori incubi. Già, perchè Slow Food, così come Eataly, è niente più che un’idea imprenditoriale che si affaccia sul mercato seguendo alla lettera le regole della produzione capitalistica: il lavoro precario, i supermercati a discapito dei centri cittadini, i grandi eventi (sostenuti da Intesa San Paolo) che oscurano i mercati contadini, le tecniche di produzione industriale che, volenti o nolenti, hanno un impatto ambientale.
Una realtà che si veste da rivoluzionaria, pur avendo rapporti diretti con enti, banche e partiti politici che di rivoluzionario non hanno nulla, che non si pone il problema della cementificazione e della devastazione ambientale, che non si preoccupa di far emergere le esperienze che davvero portano avanti istanze di trasformazione radicale della società (v. Genuino Clandestino, Campi Aperti, Rete Eat the Rich) non può essere né buona, né pulita, né giusta.
È a questo stesso sistema che è funzionale lo sfruttamento dei lavoratori e, in particolare, dei braccianti agricoli, meglio ancora se stranieri e sottoposti al ricatto del permesso di soggiorno.
Lo stesso giovedì 20 settembre è prevista la prima udienza al Tribunale di Alessandria per l’ennesimo caso di caporalato in provincia, quello scoperto dai Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Alessandria il 7 agosto del 2015 nell’azienda agricola Bovera di Guazzora. Quella fu la volta di 5 braccianti in nero e senza permesso di soggiorno. Tre anni prima, invece, a Castelnuovo Scrivia, i lavoratori in gravi condizioni di sfruttamento, che avevano cercato di rivendicare i loro diritti, erano stati licenziati con un cartello affisso sul cancello.
I titolari di queste aziende, sicuramente persone crudeli e senza scrupoli, sono anche conformi ad un modello che antepone i profitti alle persone e che impone ai lavoratori orari massacranti e paghe da fame per offrire ai consumatori prezzi concorrenziali.
È facile poi far ricadere le colpe sul consumatore che non è altro che l’ultimo anello della catena. Certo, ognuno di noi può operare le sue scelte. C’è chi fa di tutto per ridurre gli sprechi, chi si unisce ai GAS, chi acquista al mercato Equo Solidale e chi rincorre l’agricoltore che vende i suoi prodotti sul ciglio della strada. Nessuna delle nostre azioni individuali, però, può generare una trasformazione complessa e complessiva.
Nessun progetto di integrazione dei migranti attraverso l’agricoltura può arginare il caporalato, tanto meno se si pone in sintonia con l’attuale modello di organizzazione del lavoro.
Nessun cambiamento nei consumi sarà possibile senza un cambiamento dell’intera filiera produttiva. Nessuna trasformazione della società può compiersi senza conflitto sociale.
Autrice
ph. Paolo Gambaudo