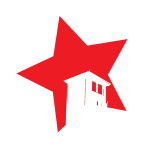Io consumo, tu consumi, egli consuma, noi consumiamo, voi consumate, essi consumano. Cosa? Tempo, emozioni, sesso, caffè, sigarette, sostanze stupefacenti ecc…
Parlare di consumi non è facile, né scontato, occorre un approccio attento e consapevole, libero da pregiudizi e semplificazioni. Negli ultimi trent’anni si sono evolute notevolmente le forme interpretative e discorsive che leggono il fenomeno del consumo di droghe: prima era perlopiù inteso quale atto di rinuncia, di fuga dalla realtà, come sintomo di disadattamento e marginalità; oggi la droga è un mezzo volto a intensificare il piacere, facilitare le relazioni e costituisce per molti un rifugio dalla routine quotidiana.
Le vicende che segnano l’evoluzione delle norme e delle politiche degli ultimi anni evidenziano come la problematicità della questione dipenda da fattori che hanno poco a che fare con la dannosità delle sostanze.
Il proibizionismo è nato al fine di regolare in senso restrittivo produzione, vendita e consumo di sostanze ritenute dannose per il singolo e per la collettività intera.
È ormai chiaro e lampante come, adottando repressione e controllo si ottenga unicamente un aumento del numero di consumatori, il peggioramento esponenziale della qualità delle droghe, la crescita della popolazione carceraria e si creano le condizioni affinché il traffico illegale abbia un ruolo centrale nell’economia mondiale.
Sia i proibizionisti che gli antiproibizionisti sottolineano le difficoltà del proibizionismo nel raggiungere gli obiettivi che si è posto, primo tra tutti la sua inefficacia nella risoluzione del “problema droga”.
Nei primi anni del ‘90 si è diffuso a livello europeo un modello teorico e pratico denominato “Riduzione del Danno” (harm reduction), esso opera all’interno di politiche proibizioniste con lo scopo di promuovere un orientamento volto a migliorare le condizioni sanitarie, sociali ed economiche associate all’uso, al cattivo uso e all’abuso di sostanze psicoattive, riducendo i danni di natura sanitaria, micro sociale e macro sociale sui singoli consumatori e sulla comunità.
La Riduzione del Danno salva vite umane (1566 morti per overdose nel 1996, 266 nel 2016) e comporta benefici per il benessere della popolazione con interventi a basso costo ed elevato impatto sulla salute, individuale e collettiva.
Il consumo è infatti un fatto sociale: il cambiamento può essere duplice, quello dei consumatori attraverso il loro ruolo attivo nella maggior responsabilizzazione dei comportamenti a rischio, e quello della comunità, a cui si richiede di vedere e affrontare diversamente il fenomeno “problema” del consumo di sostanze stupefacenti
In Italia, la RdD come approccio delle politiche sulle droghe e come sistema di intervento, è stata adottata da oltre vent’anni, in accordo con le evidenze scientifiche e con le linee guida che via via venivano elaborate in molti paesi europei e a livello comunitario. Tuttavia, a causa di opposizioni ideologiche e di tagli dei fondi per la spesa sociosanitaria permane una mappa della RdD estremamente diseguale tra le regioni, e dunque anche una forte disuguaglianza nel diritto all’accesso a servizi e interventi da parte di chi consuma sostanze.
Solo lo scorso anno, nel 2017, la Riduzione del Danno (RdD) è entrata nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). I LEA sanciscono un diritto, quello per ogni cittadino di accedere a servizi e prestazioni a tutela del proprio diritto alla salute. Il 14 giugno a Torino si è tenuto il convegno “LEA. La riduzione del danno è un diritto”, una giornata in cui si è approfondita la conoscenza e avviato il confronto sui percorsi che le Regioni stanno conducendo attorno all’implementazione dei LEA, della RdD e, più in generale, delle politiche di RdD, con il contributo delle esperienze, delle conoscenze e delle proposte che su questo terreno hanno elaborato le associazioni della società civile attive nella promozione della RdD nel nostro paese, e gli operatori del pubblico e del Terzo settore.
Nonostante manchi una riflessione nazionale organica e condivisa, riflessa nella totale assenza nel contratto di governo di alcun riferimento a politiche in materia di sostanze stupefacenti, le esperienze regionali non si sono mai fermate.
I Lea devono diventare una leva, un punto di forza poiché la Riduzione del Danno non è solo un approccio, è una politica, un modo di governare un fenomeno complesso che va oltre alla patologizzazione e la repressione. Bisogna abbandonare l’assunto sempre più interiorizzato secondo il quale il fragile, il debole fa paura ed è da eliminare anziché sostenere e accompagnare. I bisogni meritano delle risposte anche quando queste non spostano voti. Maggiore sicurezza e lotta al degrado, concetti che ormai sentiamo quotidianamente, si combattono informandosi, conoscendo, mettendo al centro la persona, vivendo la diversità come una risorsa e attuando politiche di welfare inclusive che investano anche economicamente sull’ambito sociosanitario.
Ora, nel momento in cui i LEA della RdD sono vigenti e dovrebbero, una volta declinati e articolati, “andare a regime” in tutte le Regioni, rilanciare appare urgente e necessario perché la salute è un diritto fondamentale.
Autrice