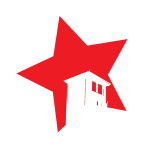20000 visitatori il giorno dell’inaugurazione, code di diverse centinaia di metri per partecipare alle presentazioni e svariati minuti di attesa anche per accedere ai servizi. Segue un weekend trionfale con un +5% di presenze rispetto al 2017 e la biglietteria che, sabato, è costretta a fermarsi per un’ora perchè gli spazi del Lingotto hanno raggiunto la capienza massima.
Si chiude oggi a Torino quella che sembra essere stata una fortunatissima 31° edizione del Salone Internazionale del Libro. Un luna park della cultura che deve però fare i conti con la procedura di liquidazione della Fondazione che fino al 2017 lo ha gestito, con i 12 dipendenti che hanno atteso il pagamento dello stipendio per due mesi e con i debiti accumulati con i fornitori.
Ma la storia, si sa, la scrivono i vincitori ed è infatti Nicola Lagioia, direttore editoriale dell’evento, che su tutti i quotidiani nazionali commenta gongolante i segnali che fanno pensare ad un 2018 da record.
Il 2018 che, tra l’altro, ha visto il ritorno a Torino dei grandi editori riuniti nell’Associazione Italiana Editori che lo scorso anno avevano deciso di chiudere con la città piemontese per fare “Tempo di libri” a Milano. Pace fatta. Mondadori torna ad occupare i suoi metri quadrati nel Padiglione 2, mentre per gli editori indipendenti si allestisce in fretta e furia una tensostruttura che si chiama Padiglione 4, ma che viene collocata al di fuori degli spazi espositivi.
Ecco, credo che i 30 editori sotto il tendone siano la risposta alla domanda che molte e molti di voi si staranno facendo. Ma com’è possibile che migliaia di persone accorrano al Salone Internazionale del Libro di Torino per passare ore ed ore in attesa di entrare/ascoltare la presentazione di un libro/assistere ad un dibattito/andare in bagno/bere acqua, mentre le librerie chiudono e anche nel 2017 i lettori “forti” (che leggono almeno un libro al mese) in Italia non hanno superato il 5,7% della popolazione?
Considerare marginale, in un evento dedicato alla letteratura, le realtà che attraverso il loro lavoro promuovono il fermento, l’innovazione e la sperimentazione artistica significa considerare marginale la cultura di per sé. E le conseguenze si vedono quando si spengono le luci e si chiudono le porte del Salone fino al prossimo maggio.
Nelle grandi città e nei piccoli centri di provincia nelle vetrine delle librerie, specialmente quelle che distribuiscono le produzioni di un unico editore, sono esposte le stesse identiche copertine. Sono i best seller, i libri firmati dagli scrittori e delle scrittrici incoronati re e regine del mercato editoriale. Sono i volumi pubblicati dai grandi editori, con alle spalle uffici marketing scaltri e aggressivi.
La letteratura che noi possiamo più facilmente fruire, dunque, è quella che sopravvive alle leggi del mercato e al processo di normalizzazione a cui il pensiero unico la sottopone. E’ una fetta infinitamente più piccola rispetto alle possibilità che il panorama letterario indipendente ci può offrire, anche grazie all’utilizzo di nuove piattaforme e tecnologie. Anche mettendo in discussione il ruolo stesso dell’autore e i diritti che può rivendicare sulla sua opera.
Sul numero 6 di 15121 scrivevamo “L’underground è morto. Viva l’underground”, auspicando l’emergere di “forze che siano utili all’attivazione indipendente e, col tempo, buone all’emersione dal sostrato e alla sfida dentro e contro il mainstream.” Nell’articolo si parlava di musica, ma l’analisi si adatta perfettamente anche alle altre espressioni artistiche, compresa la letteratura.
In questo senso potrebbe essere letta in maniera positiva la nascita, in questi giorni, dell’Associazione Degli Editori Indipendenti (ADEI) che si pone l’obiettivo di “rappresentare, sostenere e difendere sia gli editori indipendenti sia l’idea di cultura plurale e libera di cui sono i principali portatori”.
Nel frattempo i lettori possono fare la loro parte, camminando fino al Padiglione 4 anche dopo il Salone Internazionale del Libro.
Autrice