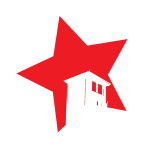Nel settembre del 2017 una delegazione di attiviste e attivisti italiani è partita per il Rojava, una regione del Kurdistan Occidentale. Il Rojava non è solo un luogo di lotta e resistenza all’Isis, ma anche un territorio in cui è in atto una rivoluzione sociale, ispirata al confederalismo democratico teorizzato da Abdullah Öcalan.
Marta Sofia, attivista e redattrice di 15121, ha fatto parte di quella delegazione e ha trascorso alcune settimane a Maxmur, nel deserto iracheno, per toccare con mano gli effetti di una diversa organizzazione della società.
Cos’è Maxmur? Prima di partire non avrei saputo rispondere, o sicuramente avrei risposto senza rendere giustizia alla potenza e alla storia di questo luogo, non avrei potuto esprimere le emozioni contrastanti che Maxmur scatena e incanala in qualcosa di più grande: l’amore per la vita e la lotta.
Maxmur si trova nel cuore del deserto iracheno, protetta su un lato da aride colline di roccia e terra, dall’altro solo il deserto che si perde all’orizzonte; nasce come un campo profughi ed ora è, a tutti gli effetti, una piccola città, conta circa 13000 abitanti, di cui più di 3500 studenti e studentesse, ma la sua storia ha inizio più di 20 anni fa ed è la sua storia a renderlo un posto unico al mondo, così differente da qualsiasi altro campo profughi.
La storia di Maxmur è una rara intersezione osmotica tra persecuzione, lotta, migrazione e resistenza al potere costituito; ha inizio nel 1993 quando la Turchia mise in campo le sue forze militari contro il Pkk, Partito dei Lavoratori del Kurdistan, in Bakur (Kurdistan settentrionale). L’esercito invase i villaggi delle province sud-orientali vicine all’Iran e all’Iraq e mise gli abitanti di fronte a una scelta: collaborare con i militari nella repressione del partito, essere uccisi o andarsene. Le azioni repressive iniziarono, i villaggi furono incendiati, la gente perseguitata, ma decine di migliaia scelsero l’esilio poichè tradire avrebbe significato tradire i propri figli, padri, sorelle e fratelli. Solo dopo 5 anni di strenue resistenza nei confronti dell’esercito turco e dei Peshmerga, nel disinteresse e silenzio dell’Unhcr (Agenzia Onu per i rifugiati), venne concesso un insediamento nell’inospitale zona desertica di Maxmur. Qui donne e uomini in lotta hanno dato vita, alla fine degli anni novanta, alla prima esperienza di applicazione del sistema di società democratica secondo le teorie di Abdullah Öcalan. La città è governata e gestita completamente dalla popolazione, attraverso il sistema della Civaka Demokratik (società democratica). 10-20 famiglie che abitano vicine formano un Komin, il nucleo organizzativo di base, che si riunisce solitamente 1 volta al mese. Il confronto e le discussioni collettive sono i principi su cui si fonda una vita comunitaria e che permettono ad essa di funzionare e svilupparsi costantemente: la costruzione di questa città ne è l’esempio tangibile.
Cosa ti ha spinto ad andare e cosa sei andata a fare? Devo innanzitutto precisare che questo viaggio non è stato un capriccio personale bensì sono partita in quanto parte di una delegazione di compagne e compagni di diverse città italiane. Siamo partiti per accorciare le distanze tra una rivoluzione in atto e tutti i percorsi che quotidianamente portiamo avanti nei nostri territori, per cancellare la distanza tra “noi” e “loro”.
Sono sicura che in pochi saprebbero dove è il Kurdistan e cosa sta succedendo in quelle terre, se Daesh (ISIS) non avesse compiuto gli attentati che hanno colpito l’Europa negli ultimi anni o se la città di Kobane non avesse eroicamente resistito all’assedio nel 2014. Prima di allora l’attenzione pubblica su quanto accade in questa porzione di Medioriente era praticamente inesistente, nonostante proprio in questi paesi ci sia stato il maggior numero di attentati e di vittime dell’ISIS. Penso che non sia possibile rimanere passivi o indifferenti, il disinteresse nei nostri paesi ha dato lo spazio di parola ai soggetti sbagliati. La presa di coscienza collettiva dell’esistenza di Daesh e della sua pericolosità si è tradotta in paranoia securitaria con tutti i suoi provvedimenti, in sciacallaggio elettorale dei partiti xenofobi contro i musulmani e gli immigrati. Questa è la reazione che rafforza l’ISIS, il cui obiettivo è scavare un solco d’odio tra musulmani e resto del mondo.
È doveroso ricordare che chi oggi combatte in prima linea l’ISIS e resiste agli attacchi dell’esercito turco non sono Salvini, Minniti o Renzi, ma sono migliaia di giovani donne e uomini curdi, arabi, assiri, turcomanni e internazionali che mettono a rischio la propria vita quotidianamente per dare concretezza ad una proposta politica alternativa valida per tutto il Medioriente e, potenzialmente, per tutta l’umanità: il confederalismo democratico.
Il terrorismo non si distrugge instillando paura, timore e sottolineando le differenze bensì mettendo queste ultime a valore, si abbatte attraverso un profondo cambiamento della mentalità e delle relazioni sociali.
Fare la rivoluzione vuol dire anche trasformare sé stessi, il proprio modo di pensare e di vivere, lo dobbiamo a tutte le persone che hanno donato la vita perché una società migliore sia possibile.
Ci sono stati momenti in cui hai avuto paura o ti sei sentita in pericolo? No, non mi sono mai sentita in pericolo, anzi spesso mi sono meravigliata di non avvertire paure o timori. Il giorno in cui sono partita mai avrei immaginato di trovarmi a pochi chilometri da conflitti a fuoco e da bombardamenti, nonostante ciò l’unico pensiero fisso era: cosa posso fare per aiutare, come posso rendermi utile?
Mi sono trovata spesso a riflettere su questo aspetto sia a caldo, ancora in viaggio, che una volta tornata. gli atteggiamenti sono frutto dell’apprendimento e quindi dell’esperienza diretta, si formano attraverso il contatto diretto, con l’esposizione ad una determinata situazione e con l’osservazione attiva del comportamento altrui e del proprio: tutti e tutte in momenti potenzialmente critici sapevano bene cosa fare e come, è una società organizzata e pronta a far fronte a qualsiasi situazione, questo ha determinato l’assenza di paure e la volontà di mettersi in gioco.
Come sono organizzate le comunità e qual è il ruolo delle donne al loro interno? L’organizzazione delle donne, come quella dei giovani, avanguardie della società democratica, è autonoma poiché rappresenta una cesura del pensiero e dell’agire dipendenti dal dominio patriarcale e dai suoi strumenti economici, feudali e capitalistici. È la rottura che rende possibile riconquistare sè stesse in un modo mai vissuto come individuale ma sempre collettivo. Questo è possibile perché migliaia di donne, madri, nonne, bambine ogni giorno mettono in gioco la loro vita e cambiano per cambiare la realtà che hanno intorno; le donne con la loro cassetta degli attrezzi nuovi e antichi, gli uomini con la necessità di rinunciare ai propri privilegi, d’indagare la propria posizione nei rapporti. Il cambiamento deve essere profondo e collettivo, la priorità è l’emancipazione delle donne come elemento imprescindibile per la realizzazione di una società libera. L’emancipazione della donna curda non è iniziata con la rivoluzione in Rojava; da decenni viene teorizzato e praticato un sistema libertario democratico che si oppone al capitalismo e all’annesso patriarcato. La lotta di liberazione delle donne viene portata avanti da organizzazioni autonome che ricoprono ogni aspetto della vita e della società: le Comuni organizzano la gestione dei conflitti nei quartieri e nei villaggi, la formazione continua contro la violenza patriarcale e capitalista, le giovani donne creano arte contro i matrimoni delle ragazze minorenni e le violenze domestiche, le Mala Jin (casa delle donne) sono le prime ad aprire nei territori sottratti alla devastazioni dell’ISIS, il comitato della Jineoloji (scienza delle donne) sviluppa e approfondisce la ricostruzione di un sapere che sappia liberarsi dall’oppressione millenaria del patriarcato.
Le donne per poter essere libere sia nella vita sociale che nella vita politica devono imparare ad autodifendersi. La difesa nasce dalla formazione: ideologica e militare. L’emancipazione femminile non va difesa solo militarmente da chi cerca di limitarla usando violenza ma anche attraverso la formazione teorica, necessaria per far sì che le donne abbiano gli strumenti per potersi difendere a livello psicologico da tutti gli attacchi a cui ogni giorno sono esposte nella società. Le donne non devono liberarsi solo da un’entità esterna come l’oppressione del regime o dello stato islamico ma anche da ingerenze interne, imposizioni implicite ed esplicite da parte della società, lottano quindi per costruire una vita libera anche all’interno delle famiglie e delle relazioni.
Qualcosa sta cambiando nel mondo, in oltre 70 paesi lo scorso 8 marzo le donne si sono riappropriate di questa data, hanno riempito le piazze al grido di “Non una di Meno”, un movimento nato in Argentina che ha avuto la capacità di diffondersi e moltiplicarsi a livello globale. Le donne tornano ad occupare lo spazio pubblico, forti di un nuovo femminismo che guarda a tutti i generi, liberandosi da futili etichette, che legge la violenza come rappresentazione di rapporti malati di potere, trasversali ad ogni aspetto della società, che avanza richieste e agisce pratiche lontane dalla retorica politica razzista e securitaria cui siamo ormai abituate. Le connessioni internazionali abbattono i confini, donano energia e fanno sentire meno sole le donne curde, italiane, messicane, polacche, irlandesi ecc…
Cosa hai riportato a casa? I giorni trascorsi assieme alle donne e agli uomini di Maxmur mi hanno insegnato molto sia dal punto di vista personale, che come militante politica.
Sicuramente ho modificato la scala di ciò che ritenevo spesso priorità ma che di fatto non lo è, e la percezione di cosa è un problema e cosa non lo è affatto, conseguentemente cambiano i sentimenti e le ansie con cui questi si affrontano nelle diverse situazioni.
Ho compreso che cosa significa essere cittadini del mondo, far parte di qualcosa di grande, del mondo intero, la realtà non finisce nel nostro quartiere, nella nostra città, regione, nazione o continente. Tutto ciò che succede nel mondo ha ripercussioni anche nel nostro quartiere. È l’odio cieco e sordo verso il diverso, che sia religione, colore della pelle, dialetto o usanze, giustificato come atto di protezione e di vendetta e mantenimento di uno status quo, a muovere gesti come quelli di Luca Traini a Macerata e di Erdogan in Siria.
Lo stato turco utilizza la posizione strategica del paese contro le potenze internazionali e l’Europa sottostà al ricatto rifugiati e terrorismo lasciando perpetrare un vero e proprio genocidio, rimanendo in silenzio e anzi condannando ogni gesto solidale che viene espresso e che prova a riportare l’attenzione su quel pezzetto di mondo che sta resistendo con tutte le sue forze, per una società migliore.
Guarda la galleria fotografica
A cura di
Fabio Bertino