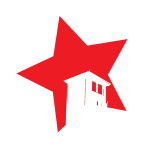Attraverso una connessione internet a banda larga è possibile avere a disposizione praticamente tutta la musica umana mai incisa di qualsiasi epoca, a costo praticamente zero: questo fenomeno si chiama streaming, ovvero ascoltare la musica online, non possedendo il supporto fisico, collegandosi a siti o applicazioni che forniscono tale servizio, come Youtube, Spotify, Tinder, Deezer e tanti altri.
Noi un po’ più vecchietti, così come le nuove leve, stiamo vivendo questa rivoluzione copernicana: tutta la musica è disponibile, sia gratis che in abbonamento secondo differenti piani di acquisto.
Lo streaming ha cambiato la musica ben più della pirateria musicale, anche perché ne è il derivato più o meno legale.
Le major della musica, e gli stessi gruppi hanno cercato per anni di porre rimedio all’inevitabile emorragia di guadagni, cercando di fornire un medium accettabile e quantificabile per l’industria musicale: “ascolti quello che vuoi” ma guardi o senti la pubblicità ogni tot, oppure paghi e senti “quello che vuoi senza interruzioni”.
In apparenza ciò può sembrare estremamente conveniente, eppure a bene vedere è un sanguinoso patto con il diavolo, perché scatena un turbinio di conseguenze: il cliente musicale spende meno, i gruppi prendono meno e tutto diventa una corsa al ribasso, dato che i gruppi hanno meno fondi per poter produrre un disco e i clienti accettano di ascoltare musica senza possederla.
Recentemente l’assemblea degli azionisti di Spotify, uno dei principali player nel mercato dello streaming, ha ribadito alla ditta la volontà di incrementare le possibilità di ascolto del fruitore gratuito (colui che non paga nulla per abbonarsi ma in compenso si ascolta moltissime pubblicità e mette a disposizione del mercato la cosa più preziosa che ha: i suoi dati).
Si capisce che qui il tradizionale capitalismo musicale è superato, i dischi servono a ben poco se non a fare un tour, vera occasione di lucro per gruppi ed etichette, anche perché lo streaming ad un gruppo rende pochissimo, ma difficilmente può rinunciare ad esserci.
Il musicista è, infatti, costretto a subire, considerato che si può permettere scelte radicali solo quando fa parte di generi molto sommersi e non vive di musica. In questo ambito il musicista che vuole vivere di musica non si può permettere di scegliere e di fare ciò che vuole.
Dall’altra parte chi sceglie Spotify spesso vi è costretto perché precario o peggio disoccupato e non può permettersi di comprare musica, di fruire della cultura, perché non ha i mezzi economici per farlo. Si rivolge, così, allo streaming (se non direttamente alla pirateria musicale), contribuendo ulteriormente alla corsa al ribasso, dove gli unici a ridere sono coloro i quali riescono a dominare i mezzi di propagazione della musica, siano essi agenzie per eventi, o azionisti di piattaforme per lo streaming, chiudendo perfettamente il cerchio. Dove si sfrutta sia il produttore che l’utilizzatore finale, e questa è l’unica vera regola del capitalismo finale, che come in una bolgia infernale sfrutta il commesso che nel tempo libero va in un negozio a comprare dove un altro commesso è sfruttato, e i prodotti sono a basso costo perché prodotti da lavoratori sottopagati negando a tutti sicurezza e gioia.
Autore
Massimo Argo
ph. Paolo Gambaudo