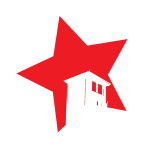Il percorso che abbiamo iniziato nello scorso numero terminava con una serie di domande dedicate ad anticipare il tempo contemporaneo in relazione con l’eredità dell’antipsichiatria. Il tempo che viviamo è profondamente caratterizzato dall’uso degli psicofarmaci: dati Federfarma evidenziano nel nostro paese un aumento dell’ 1,6% di uso di psicofarmaci antidepressivi nel 2017 rispetto all’anno precedente; dato comunque contenuto in confronto all’ 1,9% in Germania, 2,9% in Spagna e addirittura il 5,6% nel Regno Unito, nazione capitale del “pill consumption” occidentale se si escludono gli USA, dove pare che una persona su sei faccia uso di un qualche tipo di psicofarmaco.
Ben lungi dal demonizzare lo psicofarmaco in sé, il quale è uno strumento la cui utilità è indiscussa all’interno di una terapia clinica multifocale e basata sulle evidenze scientifiche del disagio psichico. Ma appunto, si tratta di utilizzare esso come uno strumento che lavora in sinergia con tutta la disciplina medica (anti)psichiatrica: la lezione basagliana in questi termini è fondamentale.
Rifocalizzando in senso clinico accademico la direzione specificatamente sociale del processo di cura, il farmaco diviene un potente strumento al servizio del medico, o meglio, della relazione che si instaura fra medico e malato-paziente. Nella proverbiale lentezza della cura della malattia psichica derivata dalla necessità del dialogo, dell’instaurare un rapporto, dello scontrarsi contro le barriere di difesa insise nella coscienza il farmaco si innesta come strumento, non come soluzione primaria.
Tuttavia da quell’anno cardine, il 1987, in cui il Prozac, uno dei nomi commerciali della fluoxetina, diventa il primo inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina ad essere messo in vendita, in una maniera del tutto funzionale all’evoluzione del presente, gli psicofarmaci sono diventati elemento pervasivo della società occidentale.
A cosa si deve questa “farmacologizzazione” della società? Come abbiamo avuto modo di citare più volte la lezione antipsichiatrica ha un fondamentale centro teoretico nel fuoriuscire dalla logica di individualizzazione del malato e del disagio per aprire la teorizzazione di esso ad una dimensione strettamente collegata al contesto sociale entro la quale si colloca.
Quella che viviamo è una società che corre a folle velocità imponendo ai soggetti la piena realizzazione materiale sulla scala di successo sociale come conditio sine qua non per la felicità.
La progressione che va da Ronald Laing per il quale il disagio psichico è una forma di autodifesa messa in atto dal soggetto per far fronte ad una situazione socio-relazionale dolorosa o sfavorevole passando attraverso l’analisi della natura schizofrenica del capitalismo dell’Anti-Edipo di Deleuze e Guattari giunge al nostro presente con chiarezza disarmante.
L’imposizione dell’efficienza, la naturale necessità del capitalismo di generare continuamente bisogni insoddisfabili, hanno creato un ambiente socio-relazionale decisamente sfavorevole, lucidamente analizzato nell’Anti-Edipo, da qui, l’assunzione della lezione antipsichiatrica da parte delle strutture del capitalismo. Fagocitata, digerita e espulsa in una veste nuova, favorevole al suo meccanismo, l’atomizzazione della società capitalistica ha introiettato l’uso dello psicofarmaco a livello capillare come forma di sostentamento alla performace-vita.
Divenuta una continua scalata al successo, un reality show in cui il prestigio sociale è dettato dal possesso e dai like ottenuti, gli psicofarmaci sono la chiave di volta per il livello minimo di efficienza imposto dai ritmi della società occidentale.
Insomma, in una maniera del tutto in linea con l’evoluzione del capitalismo il rapporto fra psicofarmaci e umanità ha sconfinato oltre la clinica finendo per pervadere una società in cui la depressione come diagnosi è in continuo aumento, specialmente fra i più giovani.
Palesemente questo dato porta alla luce l’assenza di futuro che l’umanità (non)percepisce, dopo l’ubriacatura di successo degli anni ottanta, la reazione a catena del fallimento degli anni novanta innescata dal “there is no alternative” thatcheriano, essa diviene inarrestabile col dilagare della crisi degli anni zero sino all’estremo della totale mancanza di prospettiva futura teorizzato dal Realismo capitalista di Mark Fisher per il quale quell’assenza di futuro, quella mancanza di alternativa al sistema capitalistico fatto di guerra permanente, crisi ciclica, annullamento dei diritti, è alla base della depressione epidemica dell’occidente.
Conseguenza diretta di questa epidemia sta la marea di pillole che alterano le sinapsi del meccanismo umano rendendolo efficientemente inseribile nel contesto sociale del capitalismo avanzato.
Di fatto quindi, la fondamentale evoluzione che ha permesso il superamento dell’istituzione totale del manicomio è stata perfettamente introiettata dal sistema stesso che l’antipsichiatria teoretica voleva mettere in discussione in quanto istituto totale. Introiettata e superata nel vortice del digitalismo, della scala sociale, dell’efficienza e della desiderabilità: ansia da prestazione? C’è una pillola! Catturato in un vortice di sconforto che non ti invoglia a lavorare con conseguente perdita di efficienza? C’è una pillola! Hai un momento in cui tutto questo correre a perdifiato verso un nulla fatto di centri commerciali, SUV e shopping ti sembra folle? C’è una pillola!
Philip K. Dick ci aveva visto lungo quando faceva usare il modulatore di umore Penfield ai personaggi del romanzo che ha ispirato Blade Runner.
La totale inconsistenza del meccanismo che dovrebbe regolare le società in base alla valorizzazione del modello delle relazioni sociali nella società attuale ha snaturato la lezione antipsichiatrica facendo del farmaco uno strumento di performance al servizio della macchina capitalistica.
Ciò che dell’antipsichiatria rimane è poco o nulla in confronto alla portata rivoluzionaria della sua teoria originale. Ancora di più il divenire sciame digitale degli anni dieci del duemila ed oltre non ha fatto che alimentare la distanza da una dimensione sociale ampliata, generando miliardi di bolle individuali che autoriflettono il proprio pregiudizio e il proprio disagio.
Lo sforzo teoretico che l’umanità contemporanea deve affrontare è la rivalutazione della dimensione sociale del disagio psichico. Scardinare le logiche proprie del capitalismo in materia di disagio psichico diffuso passa attraverso la rilettura della “rivoluzione copernicana” operata dall’antipsichiatria tutta e da Basaglia stesso: nella dimensione sociale dello scambio, della relazione interpersonale e di comunità sta la chiave di volta della rivoluzione di domani.
Autore